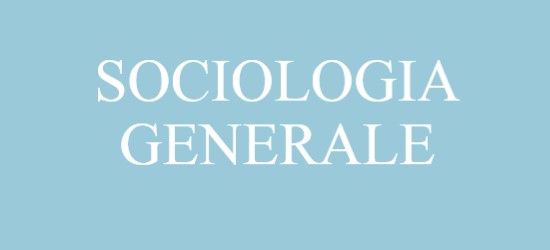La crisi dell'integrità sociale ed istituzionale.
Oltre i molti segnali di fumo
Parte Seconda
di Sergio Mantile
Segnali recenti e concreti di un avvicinamento funzionale tra le due schiere sociologiche, quella accademica e quella professionale, sono sicuramente la lettera inviata congiuntamente dalle associazioni AIS, AIST, ANS, SISS e SoIS il 22 gennaio 2020 al Ministro della Salute Roberto Speranza1 e, ancora più incisiva, la richiesta di audizione inviata dalle stesse associazioni il 4 luglio 2022 al Ministro del Lavoro Andrea Orlando2.
Mentre la prima lettera, comunque necessaria, sembra poco più di una nota dolente sottoposta al ministro che, con ben poca competenza o con molta superficialità, aveva istituito una Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie, includendovi anche psicologi e assistenti sociali, ma proprio i sociologi no, la seconda, che è una formale richiesta di incontro, è molto più programmatica. A parte la cura e il tono ufficiale della richiesta, vi si percepisce l'esigenza di presentarsi come soggetto interlocutorio coeso, e sicuramente il PNRR, con la sua eccezionalità – dell'occasione e dell'ampiezza dei fondi che rende disponibili – deve aver pesato molto in tale risultato, com'è giusto che sia. Occorre però considerare che, a fronte della potenziale offerta di finanziamento del PNRR, c'è una contingenza epocale che porta ancora una volta a rivolgere aspettative numerose e differenti alla sociologia: la crisi dell'integrità sociale ed istituzionale.
Diversi fenomeni e processi concomitanti (la tendenza a individualizzare i consumi, l’attitudine della politica italiana al controllo spartitorio e capillare delle istituzioni fin dentro ai singoli uffici, la propensione alla privatizzazione dei servizi pubblici, la delegittimazione comunicativa del confronto culturale e scientifico a favore dello scontro ludico-espressivo, ecc.) hanno finito per dividere talmente tanto ogni sequenza e sezione di attività istituzionale in Italia, che adesso l’intera società appare fortemente disarticolata, e ostacolata dalle crepe che l’attraversano. E questo, nonostante le sue risorse potenziali e persino nonostante i molti tentativi – talvolta fortemente finanziati – di porre rimedio a singole criticità.
Può essere un indicatore di senso la frequenza odierna della parola frantumazione nel linguaggio dei sociologi, quando trattano ad esempio dell’identità nazionale statunitense, o dei cosiddetti ordini mondiali tradizionali, e anche, più da vicino e in piccolo, della organizzazione e gestione di società municipalizzate, di trasporti pubblici o di smaltimento dei rifiuti, di singoli reparti ospedalieri, fino alla gestione abusiva dei parcheggi stradali. E parliamo sicuramente di forte sconnessione, se non di frantumazione, tra gli obiettivi ed i risultati di molte leggi statali. Citeremmo inutilmente a riguardo leggi urbanistiche, leggi ambientali, leggi sulla fiscalità, leggi in favore di categorie deboli e dei loro familiari.
Per decenni, l’avvio e lo sviluppo multidimensionale di tale frantumazione istituzionale è stato sia un prodotto-risultato di processi esogeni (quelli connessi alla globalizzazione) soprattutto inizialmente; e sia un obiettivo, un corso perseguito lucidamente da molti attori politici, economici, istituzionali e criminali. Una interpretazione machiavellica della deregulation reaganiana, che, attraverso procedure emergenziali – carissime alla politica, in particolare dopo il terremoto dell’Ottanta in Campania e Basilicata – riduce fortemente i controlli legali, la funzionalità costituzionale e operativa di molte istituzioni, l’accesso ai diritti dei cittadini e la partecipazione democratica.
Il welfare e la società fratturata
Conosciamo l’evoluzione del welfare soprattutto dal secondo dopoguerra agli anni Ottanta del Novecento.
In quell’epoca, le democrazie liberali occidentali non potevano essere insensibili alle povertà economica, educativa e sanitaria di tanta parte dei propri cittadini, per non orientarne o aumentarne la propensione verso ideologie rivoluzionarie e marxiste che avevano – o sembravano avere – nei paesi dell’Est europeo, la loro concreta realizzazione statuale. Per cui, per oltre quarant’anni, in qualche modo e misura, gli stanziamenti di fondi e risorse umane per il welfare state hanno rappresentato una parte dell’investimento globale nella guerra fredda, lungo un fronte che andava dalla industria delle armi fino all’assistenza per le categorie fragili.
A partire dalla fine anni Ottanta, invece, in particolare dalla caduta del Muro di Berlino, l’investimento nel welfare da parte dei governi occidentali è andato velocemente a ridursi, parallelamente al ridursi della preoccupazione per le classi povere, e insieme alla tragedia dei beni comuni, esposti ad una privatizzazione inedita e senza limiti visibili e neanche immaginabili.
Il problema è che, il welfare, dopo essere stato svalutato dai governi, è stato anche ideologicamente ricoperto di uno stigma molto negativo, l’equivalente di un costo economico a danno di cittadini virtuosi, causato da cittadini che avevano invece colpevolmente fallito in qualche cosa nel lavoro, nella famiglia o nella vita.
Nella versione italiana, dopo gli anni Ottanta, le prestazioni di welfare, nel mentre restavano ancora elevati i finanziamenti statali a molti enti, soprattutto ecclesiastici, hanno subito, insieme con una forte contrazione, anche una trasformazione funzionale.
Da una parte, da materia di richieste e negoziazioni sindacali, sono diventate strumento di voto di scambio. Cosa che, paradossalmente, ne ha aumentato lo stigma negativo, come espressione di sottogoverno.
Dall’altro, per fortuna, sono diventate occasioni per aggregare giovani e meno giovani, impegnandoli in attività assistenziali attraverso associazioni e cooperative, che oggi sono Enti del Terzo settore.
Il problema resta la società disarticolata. Perché il successo di un singolo progetto finisce spesso con il progetto stesso e gli squilibri sociali sembrano riprendere continuamente il sopravvento. Nonostante un volume di investimenti – non ancora sufficienti, ma sicuramente cospicui, di derivazione soprattutto europea – per contrastare la povertà educativa, il bullismo, la violenza di genere, ecc., non si ha la percezione di un adeguata corrispondenza, in termini di risultati sociali e della loro permanenza, al livello di quegli investimenti. É come se paradossalmente le crepe sociali riuscissero ad opporre un contrasto alle attività di contrasto alle criticità. Dal malfunzionamento dell’ufficio comunale alla competizione esclusiva tra associazioni omologhe; dal piccolo operatore economico abusivo all’assistente sociale sovraccarica di lavoro, e così continuando.
Il sociologo può svolgere la funzione dell’interconnessione del sociale, ovvero della sua ricomposizione
Adesso, però, si comincia ad avvertire da più parti e in maniera crescente, non di rado proprio da parte politica – la parte, quindi, cui imputare più o meno il processo di frammentazione sociale – una esigenza funzionale di ricomposizioni almeno parziali.
Il perpetuo divide et impera, realizzato con la segmentazione sociale, ha sicuramente giovato per qualche decennio nell’ambito delle relazioni di dominio, ma con il tempo ha finito per produrre l’ingovernabilità persino di politiche elementari. Cito un solo esempio, quello di un dirigente di un Comune dell’Area metropolitana di Napoli, che era riuscito ad accentrare talmente tanti incarichi grazie alle protezioni di una parte politica, da riuscire letteralmente a far scomparire e riapparire a suo piacimento risorse economiche dell’Ente, nascondendole nelle, o estraendole, dalle sue carte, a dispetto dello stesso sindaco, di parte politica opposta. Il quale, essendo abbastanza potente ed intelligente, alla fine riuscì a scomporre quella direzione in tre nuove direzioni, con due nuovi dirigenti. Ma ci impiegò anni.
È proprio in questo momento che la specifica competenza del sociologo sulla interconnessione e ricomposizione fra i vari aspetti del sociale può esprimersi al meglio, producendo risultati diversamente non ottenibili.
Cito un altro esempio. Con una collega, per cinque mesi abbiamo realizzato tra il 2021 e il 2022, con un finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un’attività di contrasto al bullismo in diverse scuole. Un grande successo, testimoniatoci dal referente del Ministero, sulla base delle relazioni dei Dirigenti scolastici. A mio parere, a parte l’esperienza personale, il fattore determinante è stata l’impostazione sociologica, cui le scuole non erano abituate. In particolare, il fatto di avere un approccio sistemico, che rilevava e considerava la dimensione sub-culturale in cui era inserita la scuola, lo stile di leadership della Direttrice, il rapporto tra il docente che ci coadiuvava di volta in volta e la sua classe, i rapporti fra i ragazzi, il personale non docente, talvolta anche qualche genitore. Il problema del bullismo non era mai una lezione frontale più o meno dotta sul bullismo, ma quasi sempre una descrizione delle strutture dei gruppi, delle differenze tra organizzazioni militari, criminali e scolastiche che poi, attraverso dei focus group e brevi socio-drammi, diventava coinvolgimento e confronto di esperienze personali e familiari.
Come sociologi, non entrammo in qualche forma di competizione con il docente che si occupava già da anni di bullismo, con singoli operatori o con lo psicologo, quando presente. Piuttosto, favorimmo la sinergia dei diversi soggetti coinvolti con l'adozione di una sorta di interlinguaggio (disciplinare, relazionale, posizionale, ecc.) che è, in molti ambiti, la risorsa principale del sociologo.
Bisogna tener conto del disorientamento delle persone, e soprattutto delle più fragili, quando hanno un bisogno anche molto elementare e non sanno come e a chi rivolgersi. Perché ogni istituzione, a parte che può risultare abbastanza opaca relativamente ai servizi che può offrire, agli occhi degli utenti si scompone in singoli impiegati più o meno competenti, più o meno disponibili o capaci di dare informazioni comprensibili ed utili. E, d’altra parte, ci sono uffici e operatori, che lavorano singolarmente e linearmente su una stessa questione o su uno stesso utente, senza interfacciarsi fra di loro. La verità è che questo comporta un dispendio di lavoro, di costi di ore lavoro, lasciando non di rado quasi inalterata la situazione per risolvere la quale sono stati attivati.
I sociologi che assistono, nelle loro attività operative, gruppi, cooperative, associazioni di Terzo Settore, impegnati in diversi ambiti assistenziali e formativi, monitorano continuamente i bisogni degli utenti e i contesti relazionali nei quali si esprimono, stabiliscono connessioni comunicative tra soggetti distinti e con codici differenti, per rendere comprensibili gli uni agli altri e quindi sinergici i diversi attori e le loro azioni.
In questo modo, le attività di welfare o di incentivazione allo sviluppo socio-economico (e anche economico tout court) sortiscono successi duraturi, riducono fortemente i costi di attività non sinergiche e favoriscono l’aprirsi di attività occupazionali utili alla società e alle istituzioni.
1 https://www.sociologiadellasalute.it/wp-content/uploads/2020/01/lettera-ministero-salute-22012020.pdf
2 https://drive.google.com/file/d/1AZBYUy21A25gVI8aFLNredu7giZ4vMVM/view