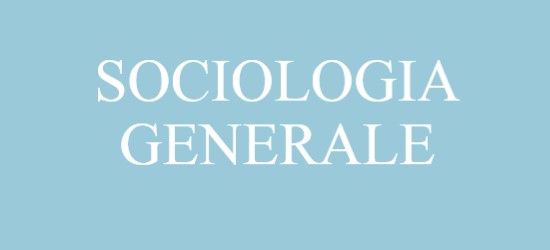Professione Sociologica
Oltre i molti segnali di fumo (e non solo) tra i sociologi accademici e quelli professionali
Un momento speciale per la Sociologia italiana (parte prima)
di Sergio Mantile
Tradizionalmente, diciamo almeno negli ultimi quarant’anni, non è corso buon sangue tra i sociologi accademici e i sociologi professionali. Almeno in Italia, perché non vi è traccia di una simile opposizione per esempio in Spagna, in Francia o in Germania (per non parlare degli Stati Uniti) dove i sociologi sono ampiamente impiegati sia nelle attività statali e para statali che in quelle private. Dove, quindi, non c’è vuoto, frattura, tra il momento formativo e quello applicativo della disciplina.
In Italia, sono sostanzialmente due i rilievi critici mossi dai tecnici, occupati prevalentemente nel lavoro sociologico, ai professori universitari, impegnati prevalentemente nella docenza sociologica.
Il primo è che questi ultimi svolgano una formazione non predisposta per un reale (o almeno realistico) esito lavorativo. In alcune valutazioni particolarmente severe, vengono considerati alla stregua di professori di scuola media superiore, le cui materie portano tutte insieme ad un titolo generico, come quello liceale, spendibile soprattutto come accesso ad un corso universitario, e non direttamente al mondo del lavoro.
Il secondo è che gli accademici e le loro associazioni non si sono mai spesi (o mai troppo o non abbastanza) presso le istituzioni governative di modo da ottenere un riconoscimento non occasionale della professione sociologica nella legislazione sociale, nei bandi di concorso pubblico per assunzioni, nella istituzione di un Albo o di un Ordine.
Senza un Ordine che garantisca standard qualitativi delle prestazioni professionali, che obblighi ad un aggiornamento costante, una parte non piccola dei laureati in sociologia, dopo aver ottenuto un titolo di dottore che non li aveva dotati di una cassetta degli attrezzi del lavoro almeno minima, finiva inconsapevolmente per ricadere – ove mai li avesse in qualche modo perduti – in concetti e linguaggio di senso comune. Pretendendo però, in virtù della laurea, che le proprie affermazioni fossero considerate specialistiche.
E questo, insieme con la mancanza di una presenza diffusa della figura nelle istituzioni e di un Ordine professionale, ha contribuito non poco ad un certo discredito sociale del sociologo, considerato spesso un “tuttologo”, un dicitore di banalità con termini astrusamente tecnici. Tale aspetto è stato sicuramente la critica principale mossa dagli accademici ai sociologi professionali. Che non studiassero abbastanza, che non si specializzassero.
A riguardo, bisogna ammettere che c’è stata, almeno in parte, una tendenza a considerare la laurea in sociologia non uno strumento per svolgere la professione sociologica, ma una sorta di passepartout per essere assunti come lavoratori dipendenti in qualche ente (come fino ad alcuni decenni fa veniva considerata da molti la laurea in legge). Ne potrebbe essere forse una conferma il fatto che la gran parte dei sociologi assunti con la legge Regione Campania n. 1 del 1983 di istituzione del servizio per la tutela della salute mentale preferì spostarsi progressivamente nei ruoli dirigenziali amministrativi piuttosto che restare su quelli specialistici operativi delle strutture territoriali.
Peraltro, nei decenni, una massa di decine di migliaia di laureati in sociologia, spinti dalla necessità occupazionale, si è vista costretta ad esplorare, con esasperazione e disperazione, strade non segnalate per spendere in qualche modo e misura sul piano occupazionale il proprio titolo di studio.
Molti hanno operato in istituzioni o progetti finanziati come sociologi e come tali sono stati apprezzati e richiesti, ma senza poter essere nominalmente e contrattualmente considerati tali. Anzi, dovendo lasciare spesso la titolarità della loro azione ad altre figure professionali, istituzionalmente riconosciute. Questo è accaduto molto spesso in ambito sanitario e socio-sanitario, generando una comprensibile frustrazione. Ma è successo anche in ambiti politico-amministrativi come enti regionali e locali e in ambiti formativi e di consulenza privati.
Comunque, molti sociologi hanno praticato la consulenza per i tribunali come CTU o come CTP; molti sono diventati docenti di istituti superiori, altri ancora amministratori di sostegno, giornalisti e blogger, socio-terapeuti, progettisti, coordinatori di progetti territoriali. Più raramente si sono impiegati come ricercatori presso enti pubblici e società di indagini di mercato.
La stessa differenza ha opposto inoltre le associazioni professionali dei sociologi accademici e quelle dei sociologi professionali, delle quali le prime – in particolare l’AIS – hanno funzionato prevalentemente in chiave quasi sindacale, promuovendo tuttavia la formazione specialistica accademica. Le seconde, almeno quelle più rappresentative, come l’ANS, presente in tutte le regioni nazionali, hanno svolto un’azione in qualche modo compensativa della mancanza dell’Ordine professionale, per esempio accreditando la professionalità anno per anno presso il Ministero di Giustizia e il Ministero del Lavoro dei soci, che avevano potuto attestare per quell’annualità un punteggio sufficiente in termini di attività sociologiche svolte.
Qualche anno fa, in corrispondenza con la necessità di collaborare per la definizione della norma UNI del sociologo, c’è stato un certo avvicinamento, tra alcune associazioni accademiche e alcune associazioni professionali, ma sostanzialmente obbligato e in qualche modo “negoziale”.
Solo molto recentemente, per diversi fattori, ultimo dei quali, ma tuttavia probabilmente il più importante, il PNRR, i segnali, di fumo ma anche sostanziali, di un avvicinamento funzionale tra le due schiere sociologiche hanno cominciato significativamente ad intensificarsi. Di seguito vedremo come e perché.