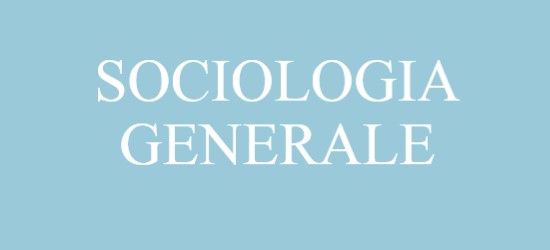Una cassetta degli attrezzi del sociologo tra mediocrità e professione.
Oltre i molti segnali di fumo: qualche riflessione conclusiva e una proposta
Parte Terza
Di Sergio Mantile

C’è stato e perdura un ulteriore fattore, tra tanti, a rendere particolarmente “inferma” la professione sociologica, anche se oggi in via di difficoltoso superamento: la mancanza di una cassetta minima degli attrezzi di lavoro.
Un medico, per esempio, ha una cassetta degli attrezzi professionale molto ricca, che conta sia strumenti cognitivi (come la semeiotica per i sintomi e i segni clinici) che un’estesa tecnologia di indagine e di intervento terapeutico, peraltro in continua evoluzione. Un avvocato praticante si dota della relativa cassetta dei suoi strumenti durante il tirocinio presso uno studio avviato, oppure direttamente in tribunale, in termini di procedure tecnico-burocratiche, di relazioni con i diversi gradi di operatori della giustizia, e persino di padronanza dei fattori psico-antropologici e ambientali. Ogni tipo di professione ha una cassetta degli attrezzi intellettuali, che spesso viene trasmessa già in ambito di formazione universitaria, o che viene acquisita con l’apprendistato lavorativo, e poi continuamente rinnovata con l’esperienza e con i corsi di aggiornamento organizzati dai diversi Ordini professionali.
La cassetta degli attrezzi svolge una funzione importantissima: media (in direzione di una prestazione standard) tra lo specifico operatore – più o meno predisposto e più o meno capace e preparato – e la soluzione al problema posto da un committente-cliente. Una sorta di volano di capacità differenziate per garantire la costanza di una performance minima attesa. La cassetta degli attrezzi, inoltre, predispone mentalmente il professionista all’ammodernamento continuo dei suoi strumenti, fornendogli motivazione e direzione di marcia.
La mancanza di un siffatto strumento per i sociologi fa virare vistosamente la forma delle loro prestazioni verso la soggettività più variegata e personalistica, esponendola alla genericità del senso comune e, soprattutto, alla mediocrità dilagante nel mondo attuale. Dal raffinato intellettuale che traguarda la realtà attraverso migliaia di pagine scritte da altri infaticabili studiosi di libri, allo scienziato che invece “si sporca le mani” nell’azione sociale, fino al praticone di auto-promozioni fittizie e comunicative da spendere in specifiche nicchie di mercato, passando per impiegati sociologi o operatori sociologi di progetti finanziati, attraverso sociologi docenti di scuola e sociologi addetti a pratiche sanitarie, sociologi tecnici informatici, sociologi blogger, ecc., singolarmente diversi per capacità e preparazione, c’è più di una cinquantina di sfumature di grigio di variazioni di senso dell’offerta di prestazione sociologica.
Il problema, allora, non è più tanto “che cosa fa il sociologo”, visto che che può essere esperto in problematiche urbanistiche e ambientali, sanitarie, lavorative ed economiche, assistenziali, di informazione e comunicazione, di educazione e sportive, giuridiche e carcerarie, allo stesso modo in cui un medico può essere specialista di dentature o di organi interni, di bambini o di anziani.
Il problema è piuttosto “cosa rende sociologica una prestazione”? Ovvero: “che cosa rende professionale e specifica la prestazione di un sociologo, su una determinata questione, rispetto alle considerazioni personali, fondate o meno culturalmente, ma slegate da vincoli teorici, tecnico-metodologici ed epistemologici, espresse su quello stesso tema da un altro soggetto qualsiasi”?
La questione, per la credibilità del lavoro del sociologo, è fondamentale.
Non si tratta di tirare in ballo l’intero edificio della teoria sociologica, nelle sue componenti storiche, analitiche e metodologiche. Il certificato di laurea ha già dato per superato tale punto.
Si tratta,“semplicemente”, di tracciare una linea di demarcazione tra le chiacchiere generiche, approssimative ed emotivamente condizionate, della sociologia perenne del senso comune1 – nella quale non di rado il sociologo non praticante, ovvero praticante di attività diverse da quella sociologica, finisce per ricadere, come in una sorta di humus mentale originario – dalle diagnosi e dalle prescrizioni scientificamente fondate di un sociologo effettivo.
Abbiamo ripetutamente criticato una tradizionale formazione accademica che non predispone adeguatamente (e spesso per niente) al mercato del lavoro, e ugualmente abbiamo lungamente criticato una politica che nega l’inserimento del sociologo nelle istituzioni per le quali è necessario e determinante, affidando le funzioni di sua competenza ad altre figure professionali.
Per completezza d’analisi, però, non possiamo scordare il contributo, involontario e tuttavia pesante, offerto alla delegittimazione della sociologia professionale da molti sociologi prevalentemente nominali. Sociologi che, pur senza praticare attività di qualche attinenza con la disciplina, non hanno più letto un libro di sociologia, un rapporto di ricerca, uno studio metodologico o una tabella statistica per dieci, venti, anche trent’anni dopo quella laurea, in virtù della quale, però, pretendono che i propri giudizi – di senso squisitamente comune – siano considerati come sociologicamente appropriati. Agli occhi di un vicino di casa, di un collega, di un interlocutore qualsiasi, quanto possono aver contribuito siffatti atteggiamenti al consolidamento dell’immagine del sociologo come inutile produttore di banalità altisonanti?
Quanto hanno contribuito ad appesantire gli sforzi di auto legittimazione di tutti quei sociologi, impegnati invece in attività lavorative dove i propri contributi professionali vengono sia utilmente sfruttati, e sia disconosciuti sul piano contrattuale e della remunerazione?
In piena mediocrazia2, quando si apprezza e si promuove la mediocrità intellettuale come competenza ultra specialistica a scapito di qualsiasi capacità di visione d’insieme (e di pensiero critico) la professione del sociologo rischia di essere doppiamente penalizzata, almeno sul piano pubblico (che però legittima e/o giustifica l’inazione politica a riguardo). Da un lato, può essere presentata e narrata come una professione generica, priva di utilizzabili conoscenze speciali; dall’altro, può sembrare dissolversi, ad opera di sociologi incompetenti, come cicaleccio nel vaniloquio diffuso di una società orientata alla mediocrità.
Si badi bene: non si tratta di installare nuove cattedre d’esame per discernere sociologi buoni e sociologi cattivi, ad opera di qualche improbabile commissione auto nominatasi per l’occasione.
Si tratta, molto più prosaicamente, di separare la sciatteria e l’approssimazione, il linguaggio inappropriato e ambiguo, le affermazioni spurie e non scientificamente argomentate non dalla perfezione, ma “solamente” dall’aspirazione razionale alla precisione, alla correttezza logica e concettuale, all’argomentazione fondata e discutibile.
Sembra incredibile, ma molte persone si offendono quasi fossero minacciate, quando sentono proporre argomenti così scontati in ambito scientifico.
Tra il dilettantismo sociale e la sociologia professionale occorre posizionare una cassetta degli attrezzi minimi del lavoro sociologico. Sarà quella a fare da spartiacque tra due mondi inconciliabili, anche se contigui. Adottare gli strumenti di quella cassetta di lavoro confermerà la vocazione ad una concezione rigorosa del lavoro, cui fornirà gli elementi d’avvio della sua pratica. Da quel punto in poi, da quella elementare base standard, saranno poi le personali qualità, la preparazione, la capacità di relazione, la disposizione empatica, l’immaginazione sociologica, l’intelligenza, la bravura e il caso a fare la differenza tra singoli sociologi, nei confronti di referenti istituzionali e privati.
La proposta
Definire i contenuti strumentali della cassetta minima del sociologo può significare, innanzitutto, darsi un compito comune per collaborare dialetticamente tra sociologi accademici e sociologi professionali. Una cassetta degli attrezzi per il sociologo, infatti, non può essere definita astrattamente, ma piuttosto attraverso un confronto serrato tra esperienze sul campo e riflessione teorica, e poi continuamente ridefinita
Punto primo: la mediocrità è un segno distintivo della nostra epoca, quasi uno standard professionale, dove l’eccellenza vale solo in termini estremamente specialistici e particolari.
Punto secondo: la mediocrità e le specializzazioni. Si può essere professionalmente sospinti e quasi obbligati alla mediocrità, però, almeno, molte professioni vicine alla sociologia, hanno almeno una cassetta degli attrezzi, più o meno grande, che
Naturalmente, ci saranno sempre medici bravi e meno bravi, e talvolta pessimi; e lo stesso vale per avvocati e falegnami, impiegati, esercenti e meccanici. E, per effetto della mediocrazia prima indicata l’assicella qualitativa tende oggettivamente al basso, come per ogni altro soggetto sociale. Ma, in questi casi, la dotazione di una cassetta minima degli attrezzi professionali garantisce in genere una prestazione mediamente accettabile. Purtroppo, non accade nella stessa misura per i sociologi.
Ai sociologi manca, generalmente, una cassetta degli attrezzi minima, sia per le moltissime specializzazioni, sia perché generalmente non viene fornita durante la formazione universitaria.
La mediocrità che taglia trasversalmente tutte le professioni, rischia di produrre, nella nostra, in assenza della cosiddetta cassetta minima degli attrezzi, maggiore danno.
1 Franco Ferrarotti, Trattato di Sociologia, UTET, Torino, 1972
2 Alain Deneault, Mediocrazia, Neri Pozza, Padova, 2017